Erano quasi riusciti a farcelo credere: la storia era finita, il capitalismo, con generale soddisfazione, costituiva la forma definitiva dell’organizzazione sociale, solo alcuni incurabili sognatori agitavano ancora lo spettro di non si sa quale diverso futuro. Lo spettacolare terremoto finanziario dell’Ottobre 2008 ha spazzato via di colpo questo castello di carte. A Londra, il Daily Telegraph scrive: “Il 13 ottobre 2008 resterà nella storia come il giorno in cui il sistema capitalistico britannico ha riconosciuto il suo fallimento”. A New York, davanti a Wall Street, i manifestanti brandiscono cartelli con la scritta: “Marx aveva ragione!”. A Francoforte, un editore annuncia che la vendita de Il Capitale è triplicata. A Parigi, una nota rivista, in un dossier di trenta pagine, analizza, a proposito di colui che si diceva definitivamente morto, “i motivi di una rinascita”. La storia si riapre…
(tratto da “Penser avec Marx aujourd’hui” del filosofo Lucien Sève)
Abstract:
Già da qualche anno, ormai, all’ordine del giorno delle principali fonti informative c’è la cosiddetta “crisi economica (o finanziaria) internazionale”.
La maggior parte dei cittadini mediamente informati, alla domanda “che cos’è la crisi”, probabilmente risponderebbero in maniera estremamente variegata, poiché, oltre a trattarsi di un argomento obbiettivamente complesso, la confusione propinata dai giornali e dalla televisione è totale. O meglio: viene detto tutto e il contrario di tutto.
I fantocci del neo-liberismo hanno, in un primo momento, provato a sostenere che si trattasse di un semplice “incidente di percorso”, salvo poi, di fronte all’evidenza, ammettere l’intensità e la pervasività del fenomeno. Da qui il tentativo di ridurre la crisi dell’intero sistema produttivo, a crisi della finanza. Questo tentativo riduzionista ha un preciso scopo ideologico: mettere sotto la lente critica soltanto l’apparenza, celando l’ingranaggio strutturale.
Questo articolo, lontano da ogni pretesa di trattazione specialistica del problema, tenta di superare alcuni dei pregiudizi caratteristici della letteratura economica “classica”, attraverso la riproposizione di alcuni concetti-chiave della critica economica marxista.
Il paragrafo introduttivo è dedicato a una breve descrizione della bolla speculativa; nel secondo si tratta di ciò che avviene quando quest’ultima esplode. Con il terzo paragrafo si entra nel vivo della crisi, e attraverso lo strumento della critica marxiana del capitalismo, si tenta di abbozzare le cause fondamentali delle “grandi crisi” economiche. Infine il quarto e il quinto parag. trattano rispettivamente di come l’imperialismo nostrano abbia affrontato il problema e di quali siano le prospettive (rivoluzionarie) per uscirne. Una volta per tutte.
I. Lo spettro della bolla che si aggira per la realtà
Se volessimo costatare tra la gente la percezione o il grado di conoscenza della crisi in atto, temo che ci troveremmo di fronte ad uno scenario alquanto confuso e ciò che ne potremmo ricavare sinteticamente sarebbe, credo, una raccolta di parole-chiave mutuate dai mass media: Stati Uniti, mutuo, ipoteche, fallimento delle banche, crollo della borsa, Lehman Brothers, aumento del prezzo del petrolio, subprime, speculazione, inflazione, Pil, disoccupazione, ma soprattutto c’è una parola che ricorrerebbe particolarmente e con la quale, queste crisi, se mai se ne vedrà la fine, sarà ricordata, la Bolla speculativa. Si, perché a svegliare tutti, compresi gli apologeti del libero scambio, è stato proprio il fragore causato dallo scoppio della bolla immobiliare USA nel Luglio-Agosto 2007.
Torniamo un attimo indietro e proviamo a spiegare il meccanismo di una bolla speculativa, in generale.
Cominciamo con una domanda introduttiva: che cosa s’intende per speculazione? Semplicemente, l’attività consistente nell’acquisto di un bene svalutato e nella sua cessione a un prezzo che nel frattempo si è accresciuto.
Uno speculatore classico gestisce un “portafoglio” immaginabile come un doppio contenitore: da una parte il denaro liquido e/o Titoli di Stato; dall’altra obbligazioni, azioni, terreni, abitazioni o merci in genere purché sottoposte a un mercato in cui il prezzo è determinato dalla domanda e dall’offerta. Queste attività sono ovviamente più rischiose ma consentono alti margini di profitto.
La “speculazione al rialzo” consiste nella riduzione delle scorte di moneta a fronte di investimenti a lungo termine. In pratica, ci s’indebita per acquistare un prodotto (materiale o finanziario) il cui valore sul mercato si suppone in ascesa, nella speranza di ottenere un profitto una volta rivenduto. Chi fa un mutuo per comprare una casa, ad esempio, s’indebita per acquistare un bene patrimoniale. Le rate annuali del mutuo sono pagamenti certi in termini monetari. Il valore della casa invece è incerto e variabile secondo l’andamento del mercato immobiliare. Facciamo un esempio semplice semplice: il sig. Rossi dopo tanti anni di lavoro è riuscito a risparmiare 50.000 euro. Decide di investirli nell’acquisto di un’abitazione che ha un costo di 150.000. quindi versa i 50.000 in anticipo e apre un mutuo al 6% annuo. L’anno successivo rivende l’abitazione per 165.000 ero guadagnando così il 4% al netto della restituzione del debito e del pagamento dell’interesse.
Oltre alla speculazione dei privati, un discorso a parte lo merita un particolare tipo di impresa i cui profitti non derivano neanche in parte dal processo produttivo ma unicamente da attività finanziarie di tipo speculativo. Queste sono le banche. Gli istituti di credito raccolgono il denaro proveniente dai clienti e lo reinvestono acquistando azioni, obbligazioni e concedendo prestiti. Più concedono prestiti, più l’offerta di moneta cresce; più l’offerta cresce, più aumenta il credito a disposizione degli altri speculatori per finanziare i loro investimenti.
In questa fase, il valore dei beni oggetto di speculazione cresce senza sosta e questo stimola gli speculatori a investire più denaro possibile in previsione di nuovi rialzi. Intanto continua a lievitare il debito privato…
Nonostante il crescente indebitamento, il fatto di possedere un bene la cui valutazione si stima in rialzo, crea un effetto fiducia che spinge ad aumentare la disposizione al consumo di ogni tipo di bene. Così cresce anche la produzione industriale (anche grazie al credito che anticipa il ciclo produttivo, come vedremo) e gli investimenti nella ristrutturazione tecnologica per far fronte alla domanda crescente. E anche il debito delle imprese aumenta…
II. E alla fine la bolla scoppiò…
Se tutto questo potesse procedere all’infinito, il capitalismo non conoscerebbe crisi. Ma evidentemente alla fine i conti tornano a galla.
Infatti, come tutti sanno, non è possibile indebitarsi all’infinito poiché il valore di un bene sopravvalutato, presto o tardi, sarà comunque destinato a subire un riequilibrio. È una semplice questione di calcolo delle probabilità: più un valore si allontana dalla sua misura originaria, più aumentano le probabilità che vi faccia ritorno. Ed è così che, quando gli speculatori più arguti sentono che i prezzi hanno raggiunto il limite, cominciano a vendere con l’intento di riacquistare una volta che i prezzi abbiano raggiunto il valore minimo. Inizia la speculazione al ribasso. Quando tutti gli altri speculatori si accorgono della tendenza, si affrettano a vendere il prima possibile, cioè prima che i beni si svalutino del tutto.
Ovviamente, questo effetto disperazione e la necessità di ripagare i debiti, fanno si che ciascuno si sbarazzi delle attività a qualsiasi prezzo, in una fase del mercato così anarchica da rendere impossibile una valutazione, per così dire, oggettiva. Vale sempre la legge secondo la quale più è estesa l’offerta di un bene più il suo prezzo è basso. Il circolo della merce diviene sempre più vizioso. Il fatto che tutti si affrettino a vendere un bene, ne fa abbassare ulteriormente il prezzo.
Tutte le tendenze che abbiamo analizzato prima, ora si invertono.
Gli istituti finanziari, che avevano inondato il mercato di liquidità, ora riducono drasticamente l’offerta di credito. La quantità di moneta circolante si contrae; si verifica, cioè, quella che Marx aveva denominato “carestia di denaro”.
La maggior parte degli investitori non è riuscita a rivendere le proprie attività o lo ha fatto in perdita e non riuscirà quindi a ripagare i debiti. Le banche che avevano prestato i soldi sono costrette a dichiarare fallimento e siccome si erano indebitate fra loro vendendo e comprando crediti sotto forma di cartolarizzazioni, i fallimenti si verificano a catena.
La percezione di povertà dilaga, i consumatori riducono i consumi e le imprese riducono gli investimenti per via del calo dei consumi e perché anche loro avevano contratto i debiti per avviare nuovi cicli produttivi determinando una sovraproduzione di merci, come vedremo.
III. Le tappe di una “caduta tendenziale”
Nel paragrafo precedente, abbiamo trattato di come i prezzi possano raggiungere valori esorbitanti per poi “sgonfiarsi” improvvisamente. Questa semplice constatazione ci dà il senso di come il prezzo di una merce non abbia un valore definito. O meglio: il valore di una cosa non corrisponde quasi mai al suo prezzo. Cerchiamo di approfondire la questione.
Che cosa determina, allora, il valore di una merce?
In generale, il lavoro in essa contenuto; la grandezza di tale valore, infatti, viene determinata per mezzo del tempo di lavoro socialmente necessario per la sua produzione.
Occorre, tuttavia, se vogliamo addentrarci nelle cause della crisi, riprendere una distinzione già introdotta da Marx ne “Il Capitale” tra “valore d’uso” e “valore di scambio”.
Il primo concerne l’utilità sociale di un prodotto, cioè la sua capacità di soddisfare bisogni umani. Per “valore di scambio” invece si intende la proprietà della merce di poter essere scambiata con altre merci, e in particolare con la merce considerata come “equivalente generale di tutti gli scambi”: il denaro.
Questa distinzione, lungi dal voler essere il frutto di una speculazione astratta, è utilissima per comprendere la scissione madre di tutte le contraddizioni che si manifestano – lo vedremo – nel processo di valorizzazione del capitale: la scissione della merce da se stessa!
La forma di “valore di scambio” assunta dalla merce nel processo di circolazione è, infatti, l’effetto di uno sdoppiamento in cui la merce diventa “altro da sé” manifestandosi esteriormente, cioè “al di là” delle sue qualità intrinseche e al di là di quella caratteristica – comune a tutte le merci – che consiste nell’essere “prodotto del lavoro”.
La merce, quindi, da “mezzo” per soddisfare i bisogni, si trasforma in mezzo per generare un profitto attraverso il plusvalore riducendo così il lavoro a “lavoro astratto” e generando automaticamente una nuova scissione tra “lavoro astratto” (tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione della merce intesa nella sua forma di valore di scambio) e “lavoro concreto” (lavoro finalizzato a produrre questo o quel valore d’uso).
Da ciò che abbiamo detto fin qui, possiamo arrivare a una prima conclusione: il valore di una merce (intesa nella sua proprietà di essere scambiabile con il denaro) è determinato dal lavoro astratto in essa contenuto.
Questa definizione parrebbe in contraddizione con quello che abbiamo affermato all’inizio del paragrafo riguardo alla disgiunzione (l’ennesima) tra valore della merce come costo di produzione, e prezzo di vendita.
In realtà non lo è affatto se consideriamo quella che all’interno del capitalismo costituisce la “conditio sine qua non” della valorizzazione della merce: la vendita.
In poche parole, il valore della merce costituito dal lavoro in essa incorporato, è un dato puramente teorico, perché se la merce rimane sugli scaffali invenduta, tutto il lavoro che si era reso necessario per produrla viene nullificato.
Siamo finalmente di fronte alla più decisiva delle separazioni, quella tra “processo produttivo” e “processo di circolazione” o, più semplicemente, tra acquisto (costi di produzione) e vendita.
Abbiamo visto prima come la forza-lavoro costituisca, nel processo di accumulazione del capitale, semplicemente un “costo” trattato alla stregua di una merce, e di cui le crisi si occupano stabilendo un riequilibrio (sarebbe a dire che nella fase di crisi viene espulsa dal processo produttivo una gran quantità di lavoratori per far fronte alla sovraproduzione).
Se la vendita si realizza, la merce acquista valore e con essa la forza-lavoro impiegata; conseguentemente da quest’ultima si estrae il plusvalore che a sua volta costituisce la base del profitto, il fine ultimo della produzione capitalistica.
Se, al contrario, la merce rimane invenduta, il processo di valorizzazione del capitale si arresta e la forza-lavoro non realizzando il plusvalore, si trasforma in passività. Una passività da abbattere. Comincia la crisi di sovraproduzione.
Nel modo di produrre capitalistico, tali crisi non sono un fatto accidentale ma ricorrono in maniera ciclica. Questo perché il fine della produzione non consiste nel soddisfacimento dei bisogni ma nell’accumulazione di capitale.
Un equivoco in cui è facile cadere, infatti, è quello di associare alla parola “sovraproduzione”, l’idea che siano state prodotte merci in eccedenza, cioè oltre i bisogni reali. Magari!In realtà le merci invendute vengono proposte sul mercato con sconti che vanno fino al 70-80% (i cosiddetti “saldi”), e poi eventualmente distrutti.
Ma perché distruggere qualcosa che può essere utilissima ai milioni di uomini e donne che, all’interno dei paesi più industrializzati, vivono in condizioni di indigenza? Perché evidentemente questa operazione influirebbe negativamente sui prezzi delle produzioni a venire e quindi, in generale, sui profitti.
Della serie, toccatemi tutto ma non il capitale!
Ma allora – potremmo chiederci – le crisi sono il frutto di un semplice errore di calcolo? Vediamo di smontare anche questa ingenuità, figlia dei pregiudizi e della malafede degli economisti “classici”.
Già agli albori del capitalismo, Marx studiando attentamente le dinamiche del lavoro e della produzione, fece una scoperta a dir poco “rivoluzionaria” e che oggi accade con la sistematicità degna di una legge fisica. In un mercato mondiale basato sulla concorrenza tra capitalisti, i costi della produzione (miglioramento delle tecniche, rinnovo dei macchinari e altri fattori) tendono a salire e per realizzare un profitto crescente occorre investire un volume di capitale altrettanto crescente (diminuzione del saggio di profitto[1]). In poche parole va aumentata la produttività. Nel frattempo però, per aumentare la competitività delle imprese sul mercato internazionale, si è scelta una politica di contenimento dei salari, il che provoca una riduzione del potere d’acquisto e quindi un calo generale dei consumi.
Un cane che si morde la coda, questo è il capitalismo.
Con la sovraproduzione, tuttavia, la crisi non è ancora manifesta. Ciò che avviene in questa fase è una generale diminuzione dei prezzi.
Per contrastare la svalutazione della merce, e per risollevare il profitto, si mettono in moto una serie di processi:
1) Aumento del tasso di sfruttamento attraverso il prolungamento del tempo di lavoro non retribuito o l’intensificazione dello stesso, o entrambe le cose (vedi il “caso Mirafiori” dove si è imposto ai lavoratori la riduzione delle pause e lo slittamento dei pasti a fine turno)
2) Incremento delle imposte indirette[2], che provoca un rialzo generale del prezzo di vendita e colpisce ulteriormente il potere d’acquisto dei salariati
3) Svalutazione programmata della moneta (il trucchetto preferito dagli USA), sempre diretta al rialzo dei prezzi
4) Intervento dello Stato secondo il principio “privatizzare i profitti, socializzare le perdite”. Tale intervento – e qui sta la creatività del singolo governo – si realizza sotto molteplici forme: dagli incentivi diretti ai consumatori (un modo “creativo” per dirottare soldi pubblici verso le imprese private), alle politiche di alleggerimento fiscale per le imprese (con la conseguenza di sottrarre ancora fondi da destinare ai servizi pubblici), passando per l’aumento delle spese militari e, in ultima istanza, attraverso un bel regalo alle banche che in politichese viene chiamato “nazionalizzazione delle banche” (all’inglese) o “salvataggio delle banche”. Fate voi.
Su quest’ultima strategia del capitale occorre soffermarsi perché è l’effetto più evidente del processo di autonomizzazione del denaro, ovvero della sua trasformazione da “equivalente generale di tutti gli scambi” a “valore in sé generante altro valore”.
Torniamo, così, finalmente all’argomento trattato nel I parag: la speculazione finanziaria.
Quello che possiamo aggiungere, a questo punto, non è altro che una puntualizzazione doverosa sulla doppia funzione assunta dalla speculazione. Da una parte, infatti, essa funge da “canale di sbocco” per il capitale sovraprodotto che trova nel mondo della finanza un’opportunità di investimento che il mercato delle merci, ormai saturo, non può offrire; dall’altra funge da “forzatura dei limiti di consumo” spingendo i consumatori a indebitarsi per acquistare beni al di là delle proprie possibilità o per investire in settori ad alto rischio.
Siamo quindi giunti a determinare la doppia causa della crisi: la causa materiale nell’indebitamento privato (di quello pubblico parleremo a parte) e la causa efficiente nella sovraproduzione delle merci e dei capitali.
Abbiamo visto, inoltre, come il credito riesca a mascherare e a ritardare (al costo, però, di ingigantirne gli effetti) lo scoppio di una crisi.
IV. Le mille facce della dea Europa
Che cosa succede, intanto, a “casa nostra”? Prima abbiamo accennato al manifestarsi della crisi dovuto allo scoppio della bolla immobiliare USA. Siamo poi andati in profondità per scoprire che l’immissione di liquidità nei mercati è semplicemente un disperato tentativo del capitale di tenersi in vita artificialmente dopo aver subito un preoccupante arresto cardiaco. Ma abbiamo visto anche che se il potere d’acquisto dei salariati continua a scendere la giostra s’inceppa e indurre questi ultimi a indebitarsi per incoraggiare i consumi, è una soluzione-tampone che non produce alcun effetto se non quello di aggravare ed estendere la crisi.
Sarebbe interessante a questo punto, confrontare i modelli di politica economica messi in atto dai vari imperialismi continentali per far fronte alla crisi del capitale, ci limitiamo, per il momento ad accennare alla situazione europea, anche perché, al momento, la sua politica si manifesta in tutta la sua problematicità rappresentando un quadro estremamente disunito e saturo di contraddizioni.
La tendenza fondamentale verificatasi dalla costituzione dell’unione monetaria del 1999, consiste nel flusso di capitali dai paesi dell’area centrale – Germania in particolare – a quelli periferici. Flusso accompagnato da bassi tassi nominali d’interesse[3] per compensare le politiche tedesche (e quindi europee) di moderazione salariale che disincentivavano la domanda.
La riduzione dei tassi e il conseguente aumento di liquidità ha favorito, secondo lo schema spiegato nel I parag. l’impiego di capitale nell’investimento edilizio che diventa quindi, così come era avvenuto negli USA, il traino di un’economia depressa.
Comincia la fase dell’indebitamento soprattutto in Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia. In questi paesi si verificano le tendenze tipiche delle bolle speculative: crescono la produttività e i prezzi, il PIL e i consumi.Ma nel frattempo, e in ciò consiste l’anomalia europea, si verifica un fattore importante che decreterà, alla lunga, il crack finanziario dei paesi coinvolti: mentre in Germania – il paese in Europa che vanta il più importante apparato industriale – i salari subiscono una compressione di circa l’1% annuo, i paesi periferici (detti anche P.I.G.S., dalle loro iniziali ma anche in senso dispregiativo) vedono incrementare i costi legati al lavoro senza, d’altro canto, guadagnare in termini di produttività. Senza, cioè, riuscire a far fronte all’aumento della domanda interna che quindi finisce per avvantaggiare le esportazioni della stessa Germania.
Riassumendo, la Germania esporta i capitali verso i paesi “porci” provocando in questi ultimi un accumulo di liquidità e un incremento della domanda; allo stesso tempo, la scarsa competitività industriale di questi paesi, dovuta al rapporto negativo tra crescita della produzione e crescita dei salari, comporta un forte aumento delle esportazioni tedesche in termini di merci aggravando ulteriormente la posizione dei paesi importatori la cui bilancia commerciale è sempre più negativa. E non finisce qui. Il surplus commerciale della Germania, non potendo essere assorbito all’interno per via della perdita di potere d’acquisto dei salari, si traduce nell’aumento del risparmio e nell’utilizzo di quest’ultimo in investimenti di capitale all’estero. Per questo le banche tedesche rappresentano oggi i maggiori creditori di Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo e questo spiega il motivo per cui il governo tedesco tiene tanto al loro salvataggio! La Germania, da una parte, vuole imporre ai paesi ad economia debole un depressivo regime di austerity, dall’altro favorisce l’indebitamento delle popolazioni per trainare le proprie esportazioni. Questa è l’Europa. Per quanto le “anime belle” socialdemocratiche si sforzino di truccarla con la loro retorica appassionata, il suo vero volto appare sempre più visibile agli occhi dei popoli. E’ il volto di un imperialismo non meno inquietante di quello a stelle e strisce che da sempre ci hanno indicato come il male assoluto. Come se si potesse distinguere un imperialismo “cattivo” da un imperialismo “buono”…
V. Riformare o superare il capitalismo?
I precedenti paragrafi hanno tentato di sciogliere alcuni nodi concernenti le teorie “classiche” attraverso le quali gli specialisti “ufficiali” hanno provato a spiegare la crisi.
Ciò che abbiamo voluto dimostrare, innanzitutto, è che non si tratta di analizzare “la crisi” ma “le crisi”. La propaganda imperialista, infatti, tenta metodicamente di parcellizzare le problematiche che si manifestano via via nel sistema dando ai singoli fenomeni un significato autonomo, un aspetto “accidentale”. Il disegno celato dietro questa teoria s’intuisce facilmente: il capitalismo non è in discussione, semmai bisogna correggere qualche regola e limitare qualche abuso. Insomma, le parole d’ordine sono riformare e moralizzare.
Moralizzare che cosa? Parlare di “eccessi” del mercato non ha alcun senso, perché, come abbiamo visto, la speculazione rappresenta nient’altro che uno sbocco dell’accumulazione capitalistica e la crisi di sovraproduzione, con tutti i costi sociali che comporta, non è altro che un aspetto organico del sistema che tende al “riequilibrio”. Certo, l’assenza di regole nella finanza, la truffaldina gestione delle imprese quotate in borsa, l’indecenza dei paracadute dorati, sono tutti aspetti che destano giustamente disgusto ma il problema è ben al di là di questi singoli fenomeni. Occorre alzare lo sguardo, mettere in discussione il dogma dell’“unico mondo possibile” e infine meditare su quella ragione ultima delle cose che Marx chiama “legge generale dell’accumulazione capitalistica”.
La vera e sostanziale immoralità consiste nel sacrificio richiesto al lavoratore: regalare parte della sua giornata all’accumulo di ricchezza da parte di chi detiene la proprietà privata dei mezzi di produzione. La contraddizione è insanabile e il senso di alienazione che ne deriva è ancora più inquietante. L’attività umana che crea ricchezza vi ha lo statuto di merce, ed è dunque trattata non come fine in sé, ma come semplice mezzo.
Il salariato, oggi come agli arbori del capitalismo, è costretto da un’implacabile maledizione a produrre la ricchezza per altri, solo producendo la propria indigenza materiale e morale. Deve perdere la vita per guadagnarla.
Qui non si tratta soltanto di denunciare l’imbarbarimento del lavoro operaio, il punto sta in una semplice ma trascurata questione: il progresso tecnologico dovrebbe sgravare l’uomo delle fatiche che lo deformano, dovrebbe consentirgli di avere più tempo a disposizione per dedicarsi alle attività cognitive, per alimentare la propria intelligenza, la propria creatività. dovrebbe, insomma, far guadagnare all’uomo l’agognata libertà. E invece ciò che fa il capitale non è altro che riprodurre costantemente una radicale separazione tra mezzi di produzione e produttori per cui ogni giorno costringe milioni di salariati a recarsi nei rispettivi posti di lavoro per vendere le loro attività produttive e cognitive, all’interno di un mercato anarchico che alla fine prende il sopravvento su di essi soggiogandoli attraverso un turbinio di incontrollabili processi tecnologici, economici, politici, ideologici.
La crisi economico-finanziaria in atto è la manifestazione, e al tempo stesso il prodotto di questa alienazione. Parlare ancora di “riforma” del sistema capitalistico è il segno più becero di un illusionismo politico duro a morire.
Occorre che a riprendere il controllo dei mezzi di produzione siano i produttori materiali, finalmente riconosciuti per quel che sono: i creatori della ricchezza sociale, aventi come tali l’indiscutibile diritto di prendere parte alle decisioni di gestione in cui si decide della loro stessa vita. Di fronte ad un sistema la cui evidente incapacità di regolarsi ci costa un prezzo esorbitante, bisogna iniziare senza indugio il superamento del capitalismo, lunga marcia verso una diversa organizzazione sociale dove gli esseri umani, grazie a nuove forme di associazione, controlleranno insieme le loro forze sociali impazzite.
[1] il saggio di profitto si esprime nel rapporto tra il plusvalore e la somma di “capitale variabile” (dedicato perlopiù all’acquisto della forza-lavoro) e “capitale costante” (dedicato all’acquisto dei macchinari, materie prime, locali, etc.)
[2] Esse colpiscono la ricchezza nel momento in cui si manifesta in maniera indiretta, ossia quando essa viene o consumata oppure trasferita. Difatti si parla di imposte sui consumi (es. IVA) o sui trasferimenti (imposta di registro)
[3] Il tasso d’interesse nominale è il tasso applicato in un atto o in un contratto di prestito, di finanziamento o di mutuo. Indica il costo teorico per chi prende a prestito del denaro ed il rendimento, teorico anch’esso, per chi lo presta. La distinzione del tasso nominale da quello effettivo si origina dalla pratica dei prestatori commerciali (banche, società finanziarie, etc.), i quali affiancano agli interessi nominalmente convenuti (T.A.N.), altri costi da sostenersi forfetariamente o percentualmente sul capitale erogato (commissioni, assicurazione, istruttoria pratica, etc.), i quali costi incidono talvolta pesantemente sul concreto rapporto economico fra le parti. Poiché il percettore dei costi accessori è sempre il prestatore, è gioco facile per questo pubblicizzare un tasso nominale estremamente interessante, salvo poi a trasferire le utilità che non ricava dal prestito su altre voci accessorie, la cui quantificazione è successiva alla fase pubblicitaria, guadagnando alla fine un valore del tutto equipollente, ma avendo venduto un prodotto finanziario nominalmente “vantaggioso”. Per questo, la legge italiana oggi obbliga i proponenti di prodotti finanziari a distinguere rigorosamente il tasso nominale (T.A.N.) dal tasso effettivo globale (T.A.E.G.)

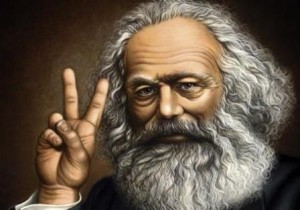
Caro compagno, innanzitutto grazie per aver letto e commentato il mio articolo.
Riguardo, però, all’interpretazione della crisi che tu mi attribuisci, credo sia il caso di chiarire meglio la mia posizione.
Le crisi cicliche, o meglio, la ciclicità delle crisi, sono solo un aspetto, uno dei tanti fenomeni, che si manifestano nell’ambito della produzione capitalistica. Come dire: il fatto che ciclicamente si verifichino crisi sovraproduttive è un dato di fatto ormai assodato, ma questo non significa che la sovraproduzione di merci costituisca la causa madre. Piuttosto quest’ultima è un effetto della “legge generale di accumulazione capitalistica” di cui ho accennato nell’articolo.
Personalmente contesto questa distinzione tra crisi strutturale e crisi ciclica per i motivi che ho appena spiegato.
Del resto, sempre nell’articolo, si parla del “saggio di caduta tendenziale del profitto” e dei meccanismi reazionari che questa legge mette in moto (intensificazione dello sfruttamento, e creazione di un esercito di riserva del lavoro).
Parlo anche della crisi di valorizzazione del Capitale, di come le ripartenze produttive non siano indice di superamento della crisi, e di come il regime di austerity imposto ai lavoratori dai vari imperialismi, influendo negativamente sul potere d’acquisto dei salariati, non fa che aggravare la situazione.
Una delle tesi al centro della mia esposizione, infatti, è proprio quella che attribuisce alla crisi finanziaria un duplice valore: quello di ritardare la recessione economica e quello di fungere da sbocco per il capitale sovraprodotto.
Nell’ultimo parag. infine, sostengo che i palliativi proposti dalle ideologie socialdemocratiche non servono a nulla fuorché a ritardare il processo rivoluzionario.
La mia formazione è lontana anni luce da quella sinistra riformista che tratta Marx come un cane rognoso. Voglio anche ricordarti, per concludere, che molti dei “compagni” a cui ti riferisci, propongono anche loro una serie di palliativi (vedi campagna per il salario sociale) che ben poco hanno a che fare con il superamento del capitalismo.
Un abbraccio. Paolo.
L’argomento che hai affrontato nell’articolo è di importanza fondamentale per tutti coloro che operano nel sociale, in
particolare per la sinistra anticapitalista; è la chiave di lettura di molti fatti politici accaduti negli ultimi anni in Italia e nel mondo, che stanno accadendo e accadranno nei prossimi anni di fronte ai quali molti compagni rimangono perplessi. L’operazione “mani pulite” che ha significato l’emarginazione di una classe politica troppo spendacciona e corrotta per la fase, voluta dai “poteri forti” con Di Pietro come strumento; la crisi del PCI e dei suoi eredi (crisi del riformismo); l’attacco alla democrazia, alla costituzione, all’informazione, le prove di fascismo( Forza Nuova, Ezra Pound) sono dimostrazioni della difficoltà del regime ad avere consenso, cosa che invece riusciva alla D.C. nella fase di dopoguerra di espansione del capitalismo; la tendenza alla guerra come guerra civile( lotta tra poveri), e guerra mondiale per la conquista dei mercati; crisi ambientale come distruzione dell’ambiente alla ricerca forsennata del profitto , fino ad arrivare a danni irreversibili (vedi l’ultimo episodio delle centrali nucleari nel Giappone; aggiungiamoci nella nostra realtà molisana la crisi del clientelismo messo in difficoltà dai tagli progressivi ai finanziamenti alla regione e al pubblico impiego, e il conseguente impoverimento del ceto medio e del lavoro autonomo, ecc.
Venendo al contenuto dell’articolo, che si presenta rigoroso e accessibile ai non addetti, c’è un aspetto fondamentale su cui si dovrebbe riflettere e discutere perchè da una interpretazione della crisi diversa da quella di altri compagni ( “uniti contro la crisi” per es.) che comporta evidentemente altri sviluppi e un’altra tattica. Parli di crisi ciclica. che all’epoca di Marx era più diffusa, che comporta come tu descrivi bene una sovraproduzione temporanea di merci dovuta sostanzialmente all’anarchia del modo di produzione capitalistico, e che rientra in tempo relativamente breve una volta esaurite le scorte e ristrutturato il sistema industriale; è la tesi che portano avanti anche la cgil di Epifani-Camusso, il PD e forse anche Tremonti ( anche il PCML tedesco): dare ai lavoratori ammortizzatori sociali anche straordinari e altri palliativi (in una situazione di debito pubblico ai limiti massimi) e attendere fiduciosi che
la produzione industriale riparta e che i lavoratori vengano reintegrati. In realtà la situazione è grave perchè stanno scadendo in tutta Italia casse integrazioni e il debito pubblico non permette di rinnovarle all’infinito; d’altro canto i tagli al pubblico impiego ,ai salari e stipendi, alle pensioni non favoriscono certo la ripresa del mercato interno. Altri compagni della sinistra anticapitalista definiscono questa crisi ( che in atto dalla fine degli 70 ( “politica dei sacrifici”) come crisi sistemica, generale, crisi di sovrapproduzione di capitale( 3 libro del”Capitale” cap15), come quella della prima metà del 900 con il culmine nella crisi finanziaria del 29 che portò a due guerre mondiali al fascismo, al nazismo ma anche all’istaurazione del socialismo in alcuni paesi. Una crisi in cui il capitale ha difficoltà a valorizzarsi, cioè non riesce ad ottenere adeguato profitto o addirittura non recupera il capitale investito, quindi preferisce non investire o investire nel settore finanziario finchè può( sovraproduzione di c. che può presentare come un aspetto una sovraproduzione di merci). Cerca naturalmente in questa fase in mille modi di abbassare il costo del lavoro per recuperare profitto, dal salario effettivo alle spese per la sicurezza , i diritti,la qualità, l’innovazione, la spesa sociale, e chiede per sè allo stato ogni forma di facilitazione. La speculazione finanziaria nasconde per qualche tempo la gravità della situazione ma prima o poi esplode (crisi finanz. del 2008) e si entra nella fase finale. Le misure che vengono prese, caldeggiate anche dalla “sinistra” (lotta agli sprechi) nel tentativo di rattoppare il capitalismo non risolvono il problema spesso lo aggravano. La chiusura dei piccoli ospedali e di reparti nel Molise, in nome di una teorica razionalizzazione, ritardata per motivi clientelari dall’amministrazione Iorio non migliorerà certo il servizio sanitario e comporterà assieme ai tagli pesanti nella scuola e nell’amministrazione una regressione nella economia regionale fino ad arrivare all’impossibilità di assicurarne la sopravivenza.
Saluti Gigi